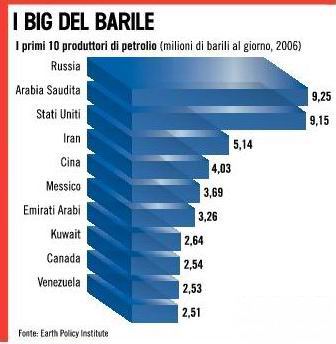| Home | chi e dove | news | agenda | documenti | varie | links | rassegna stampa |

Missione terra
Lo sviluppo è compatibile con la conservazione dell'ambiente? Un Nobel dice di sì. E in questo articolo spiega come la crescita dei diritti umani e della democrazia aiuti un'economia sostenibile e responsabile per l'equilibrio del pianeta
In che modo lo sviluppo umano si
lega alle nostre preoccupazioni per l'ambiente in generale e ai cambiamenti
climatici in particolare? Nelle discussioni politiche, le abitudini
consolidate ci inducono a considerare le esigenze di sviluppo e la
conservazione dell'ambiente in termini più o meno antagonistici. L'attenzione
spesso si concentra sul fatto che molte dinamiche che aggravano la situazione
dell'ambiente nel mondo, tra cui il riscaldamento globale e altri indizi
allarmanti di cambiamenti climatici, sono legate all'intensificazione
dell'attività economica, come la crescita industriale, l'aumento dei consumi
energetici e dell'irrigazione intensiva, l'abbattimento di alberi a fini
commerciali e altre attività tendenzialmente collegate all'espansione
economica. A livello superficiale, il processo di sviluppo può apparire
responsabile dei danni ambientali. D'altro canto, gli ambientalisti sono
spesso accusati dagli entusiasti dello sviluppo di essere 'antisviluppo', in
quanto il loro attivismo sovente assume la forma di una certa opposizione nei
confronti di processi che possono aumentare i redditi e ridurre la povertà, a
causa del loro presunto impatto negativo sull'ambiente. Le linee dello scontro
possono essere più o meno nette, ma è difficile sfuggire al senso di tensione
presente, a vari livelli, tra i promotori della riduzione della povertà e
dello sviluppo, da un lato, e i sostenitori dell'ecologia e della
conservazione dell'ambiente, dall'altro.
L'approccio basato sullo sviluppo umano offre qualche argomento che ci
permetta di comprendere se questo conflitto apparente tra sviluppo e
sostenibilità ambientale sia reale o immaginario? La logica dello sviluppo
umano può offrire un contributo enorme, adottando la prospettiva centrale che
considera lo sviluppo come espansione della libertà umana effettiva, che di
fatto è il punto di partenza di tale logica. In questa prospettiva più
generale, la valutazione dello sviluppo non può prescindere dal prendere in
considerazione la vita che le persone possono condurre e le libertà reali di
cui possono godere. Lo sviluppo non può essere esaminato soltanto in termini
di miglioramento di oggetti utili inanimati, come un incremento del reddito
nazionale lordo (o dei redditi personali). Questo è l'elemento fondamentale
che la logica dello sviluppo umano ha introdotto nella letteratura sullo
sviluppo sin dai suoi esordi, e questa intuizione riveste importanza critica
oggi per fare chiarezza riguardo alla sostenibilità ambientale. Una volta che
si riconosce la necessità di considerare il mondo nella prospettiva più ampia
delle libertà effettive degli esseri umani, diventa immediatamente chiaro che
lo sviluppo non si può separare dalle preoccupazioni ecologiche e ambientali.
Infatti, componenti importanti delle libertà umane, e ingredienti fondamentali
della qualità della vita, dipendono totalmente dall'integrità dell'ambiente,
tra cui l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, il contesto epidemiologico
in cui viviamo, eccetera. Lo sviluppo deve comprendere l'ambiente, e la
convinzione che lo sviluppo e l'ambiente debbano essere in contraddizione tra
loro non è compatibile con i principi fondamentali della logica dello sviluppo
umano.
L'ambiente talvolta è erroneamente considerato come lo stato della 'natura',
rispecchiato da misure quali l'estensione della superficie forestale, la
profondità della falda freatica, eccetera. Questa interpretazione, tuttavia, è
assai deficitaria per due importanti motivi. In primo luogo, il valore
dell'ambiente non può essere inteso solo in termini di ciò che esiste: si
devono prendere in considerazione anche le opportunità che di fatto offre.
L'impatto dell'ambiente sulla vita umana deve figurare, tra l'altro, tra le
considerazioni rilevanti per la valutazione della ricchezza dell'ambiente.
Infatti, il lungimirante rapporto della Commissione mondiale per l'ambiente e
lo sviluppo, presieduta da Gro Brundtland, 'Il futuro di noi tutti'(1987),
chiarì questo concetto, concentrandosi sul sostegno volto a soddisfare i
'bisogni' umani. In realtà, possiamo andare oltre l'accento posto dal rapporto
Brundtland sui bisogni umani e introdurre la sfera più ampia delle libertà
umane, in quanto la logica dello sviluppo umano impone di considerare le
persone non solo come 'bisognose', ma anche come individui che devono vedersi
garantita (e se possibile estesa) la libertà di fare ciò che hanno motivo di
fare.
Ogni persona ha ovviamente motivo di soddisfare i propri bisogni, e le
applicazioni basilari della logica dello sviluppo umano (per esempio, ciò che
si ricava dal semplice indice di sviluppo umano, l'Isu) si concentrano infatti
proprio su questo. Tuttavia, la sfera delle libertà può spingersi ben oltre e
una prospettiva più completa dello sviluppo umano può tenere conto della
libertà delle persone di fare cose che non sono determinate esclusivamente dai
loro bisogni. Per esempio, gli allocchi maculati possono non rappresentare, in
alcuna forma evidente, un 'bisogno' per gli esseri umani, eppure, se questi
ultimi hanno motivo di opporsi all'estinzione di tale specie, il valore della
loro libertà di conseguire questo obiettivo ponderato può essere la base di un
giudizio ragionato. La prevenzione dell'estinzione di specie animali che noi
esseri umani vogliamo preservare (non tanto perché abbiamo 'bisogno' di questi
animali in un senso specifico, ma perché riteniamo che sia una cattiva idea
permettere la scomparsa definitiva delle specie esistenti) può essere parte
integrante della logica dello sviluppo umano. Infatti, la salvaguardia della
biodiversità verosimilmente emerge come preoccupazione nelle riflessioni
responsabili sui cambiamenti climatici.
In secondo luogo, l'ambiente non è solo una questione di conservazione
passiva, è anche un obiettivo da perseguire attivamente. Non dobbiamo pensare
all'ambiente solo in termini di condizioni naturali preesistenti, in quanto
l'ambiente può comprendere anche i risultati della creazione umana. Per
esempio, la depurazione dell'acqua fa parte del miglioramento dell'ambiente in
cui viviamo. L'eradicazione delle epidemie, come il vaiolo (che è già
avvenuta) e la malaria (che dovrebbe avvenire molto presto, se riusciremo a
rompere gli indugi), è un buon esempio di miglioramento ambientale che
possiamo realizzare. Questo riconoscimento esplicito ovviamente non cambia il
fatto significativo che il processo di sviluppo economico e sociale, in molte
circostanze, può anche avere conseguenze devastanti. Questi effetti
sfavorevoli devono essere individuati in modo chiaro e contrastati con
fermezza, parallelamente al rafforzamento dei contributi positivi e
costruttivi dello sviluppo. Anche se molte attività umane che accompagnano il
processo di sviluppo possono avere conseguenze negative, rientra nelle facoltà
umane contrastare e prevenire un gran numero di tali conseguenze adottando
provvedimenti tempestivi.
Nel riflettere sulle misure che si possono adottare per arrestare la
distruzione dell'ambiente, dobbiamo individuare interventi umani costruttivi.
Per esempio, livelli più elevati di istruzione e di occupazione femminile
possono contribuire a ridurre i tassi di fertilità, il che a lungo andare può
attenuare le pressioni sul riscaldamento globale e la crescente distruzione
degli habitat naturali.
Analogamente, l'espansione dell'istruzione scolastica e il miglioramento della
sua qualità possono renderci più sensibili all'ambiente. Una migliore
comunicazione e mezzi di informazione più fecondi possono renderci
maggiormente consapevoli della necessità di una riflessione improntata
all'ambiente.
Infatti, la necessità della partecipazione pubblica riveste importanza
cruciale per garantire la sostenibilità ambientale. Altrettanto essenziale è
evitare di ridurre importanti questioni di valutazione umana, che esigono
riflessioni e considerazioni sociali deliberative, a questioni strettamente
tecnocratiche basate su calcoli stereotipati. Per esempio, esaminiamo il
dibattito in corso sul 'tasso di sconto' da applicare per bilanciare i
sacrifici attuali e la sicurezza futura. Un aspetto essenziale di tale sconto
è la valutazione sociale dei vantaggi e delle perdite nel tempo. In
definitiva, si tratta di una questione che richiede una profonda riflessione e
che deve essere oggetto di discussione pubblica, più che di un esercizio
inteso a trovare una soluzione meccanica sulla base di una semplice formula.
Forse la preoccupazione più significativa deriva dall'incertezza
inevitabilmente associata a qualsiasi previsione futura. Un motivo per essere
prudenti in merito all''ipotesi migliore' riguardo al futuro è la possibilità
che, se imboccassimo la direzione sbagliata, il mondo che finiremmo per avere
potrebbe essere estremamente precario. Vi è persino il timore che ciò che si
può impedire ora possa diventare praticamente irreversibile in assenza di
misure preventive immediate, a prescindere da quanto le generazioni future
possano essere disposte a spendere per rimediare alla catastrofe. Alcuni di
questi eventi nefasti potrebbero rivelarsi particolarmente perniciosi per i
paesi in via di sviluppo (per esempio, regioni costiere del Bangladesh o
l'intero arcipelago delle Maldive potrebbero essere sommersi a causa
dell'innalzamento del livello dei mari).
Sono questioni di importanza fondamentale per l'analisi e la discussione
pubblica, e lo svolgimento di un dialogo pubblico costituisce un elemento
significativo dell'approccio basato sullo sviluppo umano. La necessità di tali
discussioni pubbliche è tanto importante per affrontare i cambiamenti
climatici e i pericoli per l'ambiente quanto lo è per affrontare i più
classici problemi della privazione e del persistere della povertà. Ciò che
caratterizza gli esseri umani, forse più di qualunque altra cosa, è la nostra
capacità di pensare e di parlare gli uni con gli altri e di decidere che cosa
fare e poi farlo. Dobbiamo fare buon uso di questa capacità umana per
eccellenza, sia per un sostegno ragionato a favore dell'ambiente sia per l'eradicazione
coordinata della povertà e delle privazioni vecchio stile. Lo sviluppo umano
entra in gioco in entrambi i casi.
Amartya Sen
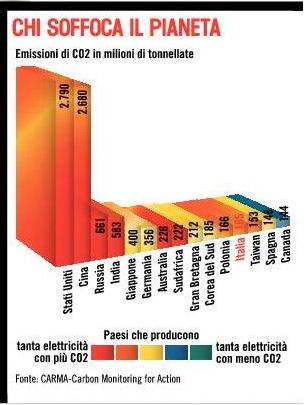
Undicesimo: non inquinare
di
La generazione di calore, le attività energivore, le auto e gli aerei. L'Unione europea propone tagli drastici alle emissioni di CO2. Ma pochi paesi si adeguano. E l'industria non vuole pagare da sola
L'undicesimo comandamento - non
inquinare - piace alla vecchia Europa della politica e delle istituzioni,
anche se non mancano naturalmente gli attriti con le lobby. E la battaglia
contro l'effetto serra pare destinata a farsi ancor più infuocata. Alla
Conferenza sui cambiamenti climatici dell'Onu, in programma a Bali dal
prossimo 3 dicembre, l'Unione europea alzerà infatti la posta della sua sfida
anti CO2: chiederà una riduzione del 30 per cento delle emissioni di gas serra
per i paesi industrializzati, e del 60-70 per cento entro il 2050. Bruxelles
ha anche reso noto che le proiezioni dimostrano che l'Europa è sulla buona
strada per raggiungere l'obiettivo di Kyoto ma deve insistere nel suo impegno.
La generazione di calore e di energia è, tra le fonti non naturali, la
principale causa del riscaldamento globale. Secondo i dati più recenti di
Enerdata, a livello mondiale vale il 39 per cento delle emissioni di CO2, la
sigla che identifica l'anidride carbonica e negli ultimi mesi è diventata il
nemico numero uno per milioni di cittadini del primo mondo. Dà il suo
contributo anche il pianeta del trasporto: il 26 per cento dell'effetto serra
è colpa di aerei, macchine, camion e veicoli di ogni genere. Sul terzo gradino
del podio si sistema l'industria, con il 16 per cento. In Italia, secondo
Legambiente, il peso dell'industria è del 18 per cento. Finora, le attenzioni
dell'Unione europea si sono indirizzate in particolare verso i produttori di
energia e le imprese che nella loro attività di energia ne consumano tanta
(come quelle siderurgiche, vetrarie, chimiche, cementiere, cartarie), provando
a mettere tutti in riga con il meccanismo dei tetti.
Dal 2005 è in vigore il sistema dell'Emission trading: se superi il livello di
emissioni di CO2 stabilito, o paghi la multa o compri i certificati verdi. Ora
Bruxelles si concentra sul mondo sui trasporti. Così, mentre discute sui
limiti di emissioni di anidride carbonica per le vetture, cozzando con la
strenua difesa dei costruttori raggruppati nell'Acea, l'Europa prova a
ripulire i cieli. Secondo le stime della Ue, le emissioni di gas serra
prodotte dai voli internazionali sono infatti cresciute del 7,5 per cento
rispetto al 2003 e dell'87 per cento rispetto al 1990. A partire dal 2011
tutti i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti dovranno emettere l'8 per
cento di CO2 in meno entro il 2012.
A ogni compagnia saranno assegnate delle quote, calcolate seconda la media
delle loro emissioni degli ultimi anni. Inoltre, come fanno già le industrie 'energivore',
potranno comparsi i certificati sul mercato. Le nuove regole avranno
ovviamente un riflesso sui conti delle compagnie e quindi anche dei biglietti.
C'è chi, come il deputato tedesco Peter Liese della commissione Ambiente,
relatore della proposta appena approvata al Parlamento europeo, ne minimizza
l'impatto finanziario sulle società: "Il sistema di scambio di quote frenerà
probabilmente la crescità del settore aereo, soprattutto quello low cost, ma
non creerà disastri economici per le aerolinee e l'effetto sul costo dei
biglietti sarà comunque minore rispetto ad altre misure, come le tasse sul
carburante o sulle emissioni di ogni singolo volo". Non la pensano così quelli
della Aea, l'associazione che rappresenta 31 vettori europei: "I signori che
hanno approvato queste nuove regole non hanno idea delle conseguenze
catastrofiche e irreparabili che ricadranno sul mercato", tuona la portavoce
Aea, Françoise Humbert.
È lastricata di aspre polemiche anche la via che porta al taglio delle
emissioni delle auto. La Commissione europea pareva lanciata a fissare un
limite di massimo 120 grammi di CO2 al chilometro alle vetture, da rispettare
entro il 2012. A fine ottobre, a Strasburgo c'è stato il ritocchino verso
l'alto: 125 grammi entro il 2015. Anche se protestano in blocco, i costruttori
non hanno tutti gli stessi problemi: gruppi come Fiat, Psa-Citroën e Renault,
che hanno nelle gamme molte vetture piccole, sono meno lontane dal limite di
quei marchi che costruiscono vetture più grosse e potenti. Progressi ne sono
stati fatti, grazie alle normative che hanno istituito i vari Euro 3 e Euro 4.
Un recente studio di AlixPartner sostiene che le emissioni globali delle auto
sono rimaste stabili nonostante il raddoppio del traffico. Spazio per
migliorare ce n'è parecchio, ma servono investimenti e vincoli normativi
stringenti per spingere i costruttori e pure il pubblico. Gli italiani
metropolitani, in particolare, dovrebbero interrogarsi a fondo sui propri
costumi, visto che a Roma e a Milano circolano 70 auto ogni cento abitanti: il
doppio rispetto a Londra e Parigi.
Alla vigilia della conferenza di Bali, promesse e proclami buonisti fioccano.
La Cbi, l'associazione degli industriali britannici, ha presentato un
programma più che ambizioso, che dovrebbe portare nel 2050 il Regno Unito a
dimezzare le emissioni di gas serra. E la commissione per lo sviluppo
sostenibile immagina che la diga progettata sull'estuario del fiume Severn,
sfruttando il moto ondoso e le maree, sia in grado di coprire il 5 per cento
del fabbisogno elettrico inglese. In Germania, il piano del governo di
coalizione tedesco, guidato da Angela Merkel, punta a una limatura del 40 per
cento delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990. E chi snobba la CO2
rischia di fare la fine di John Howard, il premier conservatore che ha
pilotato un ciclo economico record per l'Australia, con undici anni di
crescita e la disoccupazione ai minimi storici. Ha perso le elezioni perché ha
sempre sottovalutato l'effetto serra: per il 73 per cento degli australiani il
cambiamento climatico ha avuto "una forte influenza" sul voto.
In Italia, entro dicembre il governo dovrà definire la distribuzione dei tagli
alle emissioni di CO2. Una vicenda che si trascina da mesi e che da
Confindustria vedono più o meno così: l'impresa ha già fatto la sua parte,
impossibile che la sforbiciata della proposta governativa (13 milioni di
tonnellate di CO2) ricada tutta sulle spalle delle aziende produttrici.
Alfonso Pecoraro Scanio, ministro dell'Ambiente, promette un piano nazionale
di tagli prima della fine dell'anno, che andrà a toccare trasporti, terziario
e settore residenziale. Spiega Luigi Tischer, direttore generale della Robur,
azienda bergamasca che fa caldaie a pompa di calore (fattura una quarantina di
milioni di euro): "Basterebbe sostituire con pompe di calore a gas poco più
dell'uno per cento delle attuali caldaie operanti in Italia per risparmiare in
un anno 3,9 milioni di tonnellate di CO2". In Italia si considerano
all'avanguardia - e si incentivano per legge - le caldaie a condensazione, che
in Inghilterra sono obbligatorie da due anni se si costruisce o si ristruttura
un immobile.
Sul fronte dei materiali per le costruzioni, Italcementi ha brevettato TX
Activ, un principio attivo fotocatalitico per prodotti cementizi, che abbatte
gli inquinanti organici e inorganici presenti nell'aria. A Milano, rivestendo
il 15 per cento di tutte le superfici urbane a vista, si ridurrebbe
l'inquinamento atmosferico del 50 per cento. E dall'utilizzo del prodotto
all'interno del tunnel di via del Tritone, a Roma, Italcementi si attende un
calo dell'inquinamento tra il 20 e il 30 per cento.
Anche tra i piccoli imprenditori, quelli senza obblighi né tetti da
rispettare, si fa strada una certa coscienza ecologica. La conferma viene da
Sorgenia, società del gruppo Cir (editore de 'L'espresso') che vende 10
miliardi di kilowattora di energia all'anno. Il grosso della produzione di
Sorgenia - attiva anche nell'eolico e nel fotovotaico - è realizzato con
impianti a ciclo combinato che emettono oltre 200 grammi in meno di CO2 al
kilowattora: "Dei nostri 370 mila clienti con partita Iva, più della metà
svolgono attività manufatturiere: il fattore-prezzo resta ovviamente
fondamentale ma c'è il fatto che comprare energia meno nociva all'ambiente
piace, e sta pian piano facendosi largo anche come una motivazione
d'acquisto", racconta l'amministratore delegato, Massimo Orlandi.
Tornando tra le mura domestiche, significativi passi avanti hanno fatto anche
gli elettrodomestici. Lavatrici e lavastoviglie di oggi consumano mediamente
il 35 per cento in meno di quelle di dieci anni fa, e le migliori anche il 50
per cento. In questo decennio, le industrie del settore hanno investito circa
3 miliardi per migliorare l'efficienza energetica, e si sono fatte meno
sprecone nel produrre. La Indesit Company di Vittorio Merloni, secondo gruppo
in Europa, tra il 2000 e il 2006, per ogni pezzo prodotto ha diminuito del 40
per cento l'emissione di CO2, del 20 per cento l'energia impiegata e del 15
l'acqua utilizzata. E a proposito di acque, nel vicentino ottimi risultati ha
ottenuto l'Agenzia Giada. Partendo da un finanziamento europeo ha spinto il
comparto della concia della Val di Campo, il più importante d'Italia, a
ridurre in modo drastico gli scarichi dannosi in fiumi e canali e soprattutto
a diminuire la diffusione nell'aria dei solventi utilizzati per colorare le
pelli: da 18 mila tonnellate del 1996 a 7.500 l'anno scorso. Per diventare
società a impatto zero, invece, 3 Italia segue tre strade: propone i primi
videofonini Umts riciclati, rigenerando vecchi apparecchi; pianta alberi nei
parchi milanesi; assottiglia il parco auto aziendale. Calare la scure sulle
flotte aziendali prende piede: il mensile 'Quattroruote' ha convinto dieci
grandi gruppi, tra cui Autogrill, Coca Cola HBC Italia, Intesa Sanpaolo e
Pirelli Tyre, a impegnarsi a diminuire del 10 per cento le emissioni di
anidride carbonica nel 2008. Non è possibile sapere con precisione l'entità
dei tagli di CO2 della Fiat, però si sa che negli stabilimenti in cui produce
auto, il gruppo torinese nel periodo 2001-2006 ha ridotto del 31 per cento
l'uso di acqua e del 19 per cento l'emissione di composti organici volatili
per metro quadro di superficie verniciata.
Maurizio Maggi - ha collaborato Emanuele Giusto
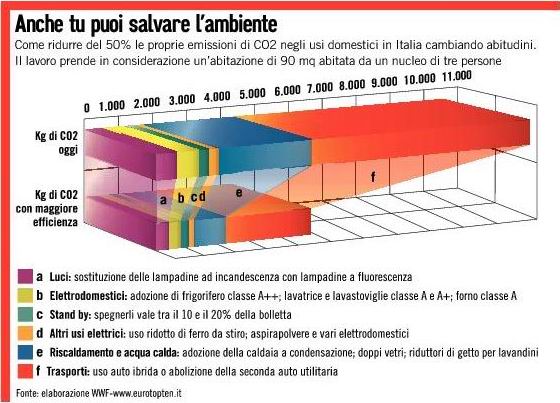
Buste di carta e semafori ecologici
A volte basta davvero poco per
risparmiare energia e inquinare di meno. Poi se al risparmio energetico si
aggiunge anche la possibilità di evitare di sporcare allora il gioco diventa
ancora più facile. A Londra lo hanno fatto e hanno deciso di prendere i
classici due piccioni con una fava.
Mai più plastica
L'idea è semplice: abolire i sacchetti di plastica in tutti i negozi della
città. Gli shopper sono infatti uno dei prodotti più inquinanti che esistono
al mondo, per una banale ragione: sono fatti di plastica non biodegradabile.
Questo vuol dire che non solo rimangono nell'ambiente per anni prima di essere
distrutti, ma anche che per fabbricarli occorre consumare petrolio e quindi
emettere nell'atmosfera anidride carbonica. Per smaltire una busta di plastica
ci vogliono in media dai dieci ai 20 anni, e nel mondo ne vengono prodotte
ogni anno circa 500 miliardi, il che vuol dire 1 milione di buste al minuto.
Ora nella capitale inglese hanno deciso di dire basta agli shopper di
plastica. Nei supermarket di Londra a partire dal 2008 ci saranno solo buste
di carta, si spera riciclata. Nel mondo hanno già eliminato gli shopper paesi
come Taiwan e Australia. Il Giappone ha invece optato per una tassa sulla
plastica seguendo l'esempio dell'Irlanda. L'Eire, infatti, ha introdotto la
tassa Plastax dal 2002, permettendo di tagliare del 90 per cento il consumo
delle buste di plastica e di rimpinguare le casse dello Stato di 8 milioni di
euro passando da un consumo di 1,2 miliardi l'anno a poco più di 200 milioni.
Anche in Italia si dovrà dire addio ai sacchetti di plastica, ma non prima del
2010.
Siamo a cavallo
Risparmiare energia per molti significa anche tornare indietro, fare un
salto nel passato. Allora se davvero è così perché non reintrodurre i cavalli
e i carri trainati da cavalli? Sembra uno scherzo o la provocazione di qualche
ostinato oppositore alle politiche di risparmio energetico. Invece è una
soluzione a cui hanno fatto ricorso in Francia 70 sindaci di altrettante città
e cittadine d'Oltralpe. Invece di usare bus
e camion per svolgere alcuni servizi pubblici, in queste cittadine sono
tornati i cavalli. E l'idea piace, soprattutto ai ragazzi di Saint Pierre sur
Dives nel Calvados che invece dello scuolabus hanno a disposizione una
bellissima carrozzella. E piace anche ai netturbini di Trouville, in Normandia
che usano i cavalli per trainare carretti dove si trasportano rifiuti
rigorosamente riciclabili. All'aeroporto di Beauvais, un centinaio di
chilometri a nord di Parigi, i carretti a cavalli portano anche i container
dell'acqua per pulire le strade. Felici sono anche quelli dell'associazione
francese Haras Nationaux (cioè l'organizzazione nazionale dei cavalli
originari) che al meeting annuale dei sindaci francesi ha esposto un modello
per un nuovo carretto, l'Hippoville, dotato di freni a disco, fari e sedili
asportabili (costo: 11.562 euro optional inclusi.
Luce sul risparmio
In città ci sono luci sempre accese. Sono quelle dei semafori. Sostituire
le lampadine usate negli impianti di regolazione del traffico con lampade ad
alta efficienza sarebbe un bel passo in avanti. Prima a farla nel mondo è
stata Roma. Nella capitale gli ecosemafori sono già una realtà. Con un
risparmio dell'88 per cento dei consumi.
Emanuele Perugini
Il papa è verde ma il patriarca lo è di più
L'ultima volta è stata a Loreto il
2 settembre, tra gli ulivi in vista del mare. Predicando a mezzo milione di
giovani, Benedetto XVI li ha incitati a "ricreare una forte alleanza tra
l'uomo e la terra, prima che sia troppo tardi". Ma l'ecologia compare di rado
tra le questioni affrontate da questo papa. Di rado e per brevi cenni. Tra i
capi delle Chiese cristiane il capofila della battaglia per la salvezza del
pianeta è indiscutibilmente un altro, è il patriarca ecumenico di
Costantinopoli Bartolomeo I. Una celebrità del ramo, Al Gore, ex
vicepresidente degli Stati Uniti, si è recato da lui in visita e l'ha salutato
come 'il patriarca verde'. Con buoni motivi. Bartolomeo I si spende anima e
corpo per la 'salvaguardia del creato' da vent'anni, dal primo meeting
internazionale di leader religiosi da lui convocato sul tema, nell'isola di
Patmos, quella delle visioni dell'Apocalisse. La qualifica di 'patriarca
verde' lo accompagna ormai sulla copertina dei suoi libri. L'ultimo, uscito
negli Stati Uniti nel 2003, ha per titolo: 'Grazia cosmica e umile preghiera.
La visione ecologica del patriarca verde Bartolomeo I'. Un altro libro è
imminente.
Ma più che scrivere, Bartolomeo I gira il mondo. Ha cominciato nel 1995 con
una crociera nel Mar Egeo che era un simposio galleggiante finalizzato alla
causa. E da lì in avanti non s'è più fermato. Nel 1997 ha organizzato un nuovo
simposio-crociera nel Mar Nero. Nel 1999 sul Danubio. Nel 2002 nel Mare
Adriatico, con tappe negli antichi domini bizantini, a Ravenna, a Venezia. Nel
2003 nel Mar Baltico. Nel 2006 sul Rio delle Amazzoni. Quest'anno, dal 6 al 13
settembre, nei mari della Groenlandia, a bordo di un rompighiaccio. Ai simposi
acquatici di Bartolomeo I partecipano esponenti di tutte le religioni e di
tutte le fedi in madre natura. Per amor di pace, quando pregano insieme, la
regola è il silenzio: si riuniscono in coperta ammirando lo spettacolo delle
acque.
Nella tappa di Venezia della crociera del 2002 Bartolomeo I emise una
dichiarazione congiunta a nome suo e di Giovanni Paolo II. Da allora, prima di
ogni nuovo simposio, il papa invia a Bartolomeo I un messaggio di adesione e
designa un proprio rappresentante. Quest'anno, in Groenlandia, l'ambasciatore
del papa fu il cardinale americano Theodor McCarrick. L'anno prima, sul Rio
delle Amazzoni, era stato il cardinale Roger Etchegaray.
Benedetto XVI, che ha in simpatia Bartolomeo I, delega a lui volentieri
l'impegno diretto per la difesa della natura. Personalmente, infatti, papa
Joseph Ratzinger diffida dal mescolare la Chiesa cattolica a una cultura
ecologista in cui vede serpeggiare mode neopagane. Facciano gli altri. A lui,
al papa, preme di più distinguersi che associarsi. Preme di più dire al mondo
quelle parole venute dall'alto che il mondo, da solo, non sa pronunciare.
Sandro Magister
E sulle emissioni l'Europa fa flop
Un mercato da 3 mila miliardi di
dollari e 25 milioni di posti di lavoro aspettano chi, entro il 2050, saprà
sviluppare e vendere tecnologie pulite. Cioè fonti di energia rinnovabile,
macchine più efficienti, e quanto altro serva a curare la dipendenza mondiale
da petrolio, carbone e metano. Sarà una 'rivoluzione industriale', come ha
detto la Commissione europea. Ma a beneficiarne potrebbe non essere l'Europa.
Gli obiettivi di taglio delle emissioni europee non servono solo a rallentare
l'effetto serra, ma anche, e soprattutto, favorire lo sviluppo e la diffusione
interna di nuove tecnologie. Per creare un primato di conoscenze che i paesi
europei possono rivendere sul mercato mondiale. Ma secondo il nuovo Piano
strategico per la tecnologia energetica (Set-Plan), appena pubblicato dalla Ue,
l'Europa sta fallendo questi obiettivi e perdendo la corsa. Di questo passo,
finirà per importare tecnologie pulite da paesi come gli Usa, la Cina e
l'India, che non hanno ratificato il protocollo di Kyoto.
Un danno e una beffa che la Comunità attribuisce all'inefficienza dei sistemi
di incentivi nazionali, oltre che a una scarsa attenzione per la ricerca.
Vediamo più da vicino il caso italiano, le cui falle sono esemplari. Per
incentivare la produzione di energia rinnovabile, l'Italia si e affidata
principalmente al sistema dei Certificati verdi. Questi attestano la
produzione di elettricità da fonti rinnovabili e possono essere venduti su un
mercato interno. Li acquistano i produttori di elettricità da combustibili
fossili, che per legge devono coprire una quota di produzione in modo
eco-compatibile. In teoria, il prezzo dei certificati dovrebbe rendere
conveniente la produzione di energia rinnovabile, incoraggiando la conversione
delle centrali.
Il sistema sembra funzionare in paesi come la Gran Bretagna, che hanno imposto
parametri molto rigidi a tutti i produttori di elettricità: oltre il 10 per
cento da fonti rinnovabili entro il 2011. In Italia, invece, gli obblighi sono
piuttosto modesti: nel 2010 la produzione da fonti rinnovabili dovrà essere
poco più del 5 per cento del totale. Che in realtà sarà un 2,5 per cento,
perché metà della produzione elettrica è esentata dagli obblighi di legge,
grazie a varie 'scappatoie' legali. Anche gli incentivi per migliorare
l'efficienza prestano il fianco a diverse critiche. A partire dal sistema dei
Certificati bianchi, analogo a quello dei Certificati verdi. Che non sembra
favorire a sufficienza l'adozione di tecnologie innovative. "Il 55 per cento
dell'obbligo di efficienza per le aziende è soddisfatto semplicemente montando
lampadine a fluorescenza", spiega Matteo Leonardi, economista consulente del
Wwf. E rincara: "Se la priorità nazionale è davvero l'efficienza energetica,
perché la finanziaria non impone che le apparecchiature elettroniche per la
pubblica amministrazione siano selezionate in base all'efficienza? Perché non
si impone che le scuole, ospedali e caserme da ristrutturare migliorino
l'efficienza? Perché non fare lo sgravo sull'Ici solo a chi ha la casa più
efficiente? Perché non si tolgono dal mercato le lampadine a incandescenza?
Sostituendole tutte, in un anno si risparmierebbe l'equivalente di una
centrale nucleare".
"Uno dei problemi maggiori è che, anche quando abbiamo le risorse finanziare,
non riusciamo a spenderle", spiega il direttore del Ministero dell'ambiente
Corrado Clini. E fa l'esempio del fondo da 600 milioni di euro, istituito
dalla finanziaria 2007 per incentivare, in tre anni, interventi nell'industria
e nell'edilizia. Ne parla anche la finanziaria 2008, ma finora non ne è stato
speso un centesimo. "Gli interventi da fare erano già stati individuati nel
2007, e avrebbero rappresentato un volano importante, producendo investimenti
per oltre un miliardo e mezzo di euro", dice Clini: "Ma non siamo ancora
riusciti a farli partire, perché le procedure per avviare il fondo non sono
state completate". Se anche funzionassero a pieno regime, tutti gli incentivi
previsti oggi in Italia non basterebbero nemmeno lontanamente a rispettare gli
impegni presi con l'Europa di Kyoto. In qualche misura, è un problema che
riguarda la maggior parte dei paesi europei, e il Set-plan vorrebbe risolverlo
coordinando gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e convogliandoli
verso le tecnologie più promettenti. Cioè eolico, solare, biomasse, fissione
nucleare, stoccaggio sotterraneo dell'anidride carbonica, e una rete elettrica
pan-europea che ridistribuisca su tutto il continente l'energia con essi
prodotta.
Ma il documento sorvola sulla questione più spinosa, non spiegando come
l'intero piano sarà finanziato. Se ne parlerà a marzo, durante il prossimo
Consiglio europeo di primavera.
Daniele Fanelli

Ecobomba Indonesia
La corsa a disboscare Sumatra libererà 49 miliardi di tonnellate di CO2. Un disastro senza precedenti. Per produrre olio di palma destinato anche all'Italia
Riau è un puntino sulla carta
geografica, una provincia dell'Indonesia laggiù, in mezzo all'isola di Sumatra.
Dovremmo abituarci a familiarizzare con quel nome esotico e non per
immaginarci vacanze in un Paradiso. Quando si degrada, il Paradiso perduto
diventa minaccia globale, nel Pianeta interdipendente. Se si distrugge, come
sta succedendo, la torbiera di Riau, poco più di 4 milioni di ettari, la
stessa estensione della Svizzera, si liberano nell'aria 49 miliardi di
tonnellate di anidride carbonica, cioè l'equivalente di emissioni di gas serra
di tutta la Terra per un anno. Il dato, clamoroso, è di Greenpeace. Se si teme
possa essere di parte, è confermato dagli scienziati indipendenti dell'Ipcc
(Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico), un organismo delle
Nazioni Unite. Cosa possiamo fare qui per quello che succede là? Semplice:
ridurre l'uso dell'olio di palma. O non usare olio di palma che arriva
dall'Indonesia. Quale connessione c'è tra la torbiera e l'olio di palma è
domanda che merita una spiegazione larga.
Premessa. Le foreste che ancora esistono trattengono 500 miliardi di carbonio.
Le foreste torbiere, in particolare, hanno la prerogativa di immagazzinare
carbonio nel primo passaggio della materia organica verso la fossilizzazione
che può portare alla trasformazione in carbone o petrolio. Hanno svolto
egregiamente questo lavoro nel corso dei millenni. Ora vengono aggredite.
Negli ultimi 50 anni circa 74 milioni di foresta indonesiana sono andati
perduti. Il ritmo è cresciuto negli ultimi anni (due milioni ogni 12 mesi,
l'equivalente del Belgio). Motivo primo: il commercio di legname pregiato.
Solo il motivo primo. Ché il peggio succede dopo. Una volta tagliati a raso
gli alberi, il terreno viene drenato per la costruzione di canali di trasporto
dei tronchi. Nonostante sia vietato, la biomassa residua viene rimossa col
fuoco. Gli incendi servono per diminuire l'acidità del terreno, concimano ed
eliminano potenziali parassiti. È in quest'ultima fase che vengono rilasciati
i gas serra in una quantità stimata all'anno di 1,8 miliardi di tonnellate: il
4 per cento delle emissioni globali da meno dello 0,1 per cento delle terre
emerse. Tanto da issare l'Indonesia al terzo posto tra i Paesi inquinanti dopo
due colossi come Stati Uniti e Cina. E senza pagare dazio, perché è
considerata una nazione in via di sviluppo e dunque non è obbligata a ridurre
la quota di gas serra, secondo i dettami del protocollo di Kyoto.
Ma torniamo alla foresta. Una volta bruciata, è pronta per nuove coltivazioni.
Il business vuole che le più convenienti siano quelle di palme da olio. La
palma è una pianta generosa, il corrispettivo vegetale del maiale: non si
butta niente. L'olio che se ne ricava ha i più svariati usi: entra nei
prodotti alimentari, nei cosmetici. I suoi derivati sono ingredienti comuni
nei foraggi compositi e vengono utilizzati da poco, sui larga scala, per i
biocarburanti. Negli ultimi dieci anni l'uso di olio da palma, nel mondo, è
aumentato del 75 per cento. Nell'Unione europea è raddoppiato fino a coprire
il 13 per cento del totale. Per l'eterna legge della domanda e dell'offerta
l'incentivo per i Paesi produttori è enorme. E così in Indonesia si procede a
ritmi forzati: giù gli alberi, via agli incendi, sotto con le piantagioni.
Bastano 4-5 anni per avere palme in produzione. Le esportazioni di olio sono
cresciute del 244 per cento dal 2000 ad oggi. Stime prudenziali vogliono che
la richiesta di olio da palma raddoppierà entro il 2030 e triplicherà entro il
2050. Ammonisce Nichola Stern, ex vicepresidente della Banca mondiale: "La
domanda aumenta e le riserve di carbonio delle torbiere indonesiane
precipitano. Ciò che stiamo facendo oggi stende un'ombra che oscura il nostro
futuro. Le politiche ambientali devono incentrarsi sui rischi dello sviluppo
economico e andare oltre quei cambiamenti marginali che sono diventati il pane
quotidiano degli economisti". Tradotto: non bastano soluzioni soft, bisogna
procedere con l'accetta (se il termine, nel contesto, non stride...) per
ridurre i gas.
Paradosso vuole che l'olio di palma fosse stato salutato, agli esordi, come un
toccasana per il clima perché, nella versione biocarburante, inquina meno dei
combustibili fossili derivati dal petrolio. Utilizzandolo, le aziende hanno
diritto ai certificati verdi dell'Unione europea. Non si era tenuto conto dei
danni procurati all'origine. Un rapporto dell'Epea (prestigioso istituto
internazionale di Amburgo) calcola che, in un periodo temporale di 100 anni,
la produzione di biodiesel da olio di palma tratto da una piantagione su
torbiera, emette una quantità di anidride carbonica cinque volte superiore di
quella delle normali benzine. Ne è consapevole Fabrizio Fabbri, funzionario
per l'ambiente della rappresentanza permanente dell'Italia all'Unione europea:
"Proprio per questi motivi da tempo ho chiesto di togliere l'olio di palma dal
novero dei prodotti che danno diritto ai certificati verdi e di stabilire
criteri di sostenibilità ambientale per ogni tipo di produzione".
La politica cerca rimedi. Greenpeace agisce. E lo fa in un momento cruciale.
Dal 3 al 14 dicembre si terrà proprio a Bali, in Indonesia, il vertice
mondiale sul clima per discutere la seconda fase del Protocollo di Kyoto.
Ottima occasione per lanciare un allarme dove la battaglia è cruciale.
Individuato nella provincia di Riau il luogo dove più copiosi sono gli incendi
della torbiera (e dove esiste la più alta concentrazione di carbonio
immagazzinato mai riscontrata al mondo), i suoi attivisti hanno impiantato
nell'area un Campo di resistenza forestale. Azioni spettacolari e indagini in
loco. Oltre ad abbordaggi di navi che portano in Europa l'olio, come è
successo ad esempio questa settimana a Rotterdam. Il tutto ha anche prodotto
un rapporto scientifico, dal titolo 'Come ti friggo il clima' in cui punta
l'indice contro la "ristretta squadra di giocatori molto potenti che
controllano una grossa fetta del mercato". Anzitutto la Cargill, la più grande
società privata del mondo, poi la Adm-Kuok-Wilmar, gigante dei biocarburanti,
infine la Synergy Drive, società controllata dal governo malese in grande
espansione e che minaccia il primato delle altre due. Il rapporto di
Greenpeace si concentra anche sui big dell'agroalimentare che usano l'olio di
palma indonesiano per prodotti di largo consumo disponibili negli scaffali dei
supermercati: Unilevel (margarina Flora), KitKat, Pringles, Philadeplhia,
Gilette, Burger King, McCain, per dire delle più note. La richiesta è
semplice: comprate altrove la materia prima e badate non sia a danno del
pianeta. Poi la piattaforma che sarà presentata al vertice sul clima: fermare
la deforestazione in tutto il mondo; stabilire una moratoria sulla conversione
agricola delle torbiere; ripristinare le torbiere indonesiane degradate.
Risparmio totale: quattro miliardi circa di anidride carbonica l'anno. Non è
risolutivo. Però permette al paziente Terra di liberare un po' i polmoni.
Gigi Riva
Grandi marchi
sotto accusa
E l'Italia? Le nostre imprese acquistano olio di palma in misura sempre crescente da Nuova Guinea (53 per cento), Indonesia (44) e Malesia (2). Il marchio più popolare è quello della Ferrero che, alle accuse di Greenpeace, ribatte: "Dal 2005, coscienti della problematica, partecipiamo al programma 'Round table on sustainable palm oil' (Rspo) che si muove per una produzione continua e responsabile nel rispetto delle foreste equatoriali". Fa anche notare che la Rspo fu lanciata dal Wwf. A Greenpeace non basta: "I criteri stabiliti da Rspo non vietano la conversione di foreste in piantagioni di palme". Merloni Progetti viene chiamato in causa per i progetti di biodiesel con la partecipata Nusantara di Sumatra. Ribatte l'ad Marco Marchioni: "Abbiamo quote minime di partecipazione, perché ce lo chiedono, a garanzia, i nostri partner. Noi ci limitiamo a progettare impianti. E stiamo studiando, sempre più, l'utilizzo di oli riciclati o provenienti da grassi animali". Ancora Greenpeace: "Dai documenti ufficiali risulta che Merloni ha un ruolo, oltre che nella progettazione, anche nella gestione degli impianti".

PETROLIO ADDIO
L'Arabia Saudita è già arrivata al massimo della produzione. E la scoperta di nuovi grandi giacimenti è sempre più rara. Secondo uno dei massimi analisti ambientali, è la fine di un'era durata oltre un secolo - colloquio con LESTER BROWN
Per il petrolio il 2007 è l'anno
dei record: il barile viaggia sui 100 dollari e nonostante ciò, per la prima
volta nella storia, la produzione di greggio cala. Gli 84,8 milioni di barili
al giorno del 2006 sono diventati 84,6 nei primi dieci mesi dell'anno. Sembra
un'inezia statistica, ma per gli esperti, abituati alla crescita continua
della produzione, è uno choc. Molti si chiedono se la produzione di petrolio
sia arrivata ormai al suo picco storico.
È quanto sostiene da alcuni anni Lester Brown, che trent'anni fa fondò il
WorldWatch Institute e oggi dirige l'Earth Policy Institute a Washington. Fino
a ieri la sua tesi non veniva presa sul serio dall'industria energetica e
dalle grandi istituzioni dell'economia mondiale. Ma ora l'idea che siamo
arrivati a una svolta si fa strada anche tra gli esperti. Nel corso di una
conferenza dell'industria petrolifera, che si è svolta il 31 ottobre a Londra,
il presidente della ConocoPhilips, James Mulva, e il capo della francese
Total, Christophe de Margerie, hanno entrambi affermato che la crescita del
petrolio è arrivata al capolinea, e in ogni caso non potrà superare i 100
milioni di barili al giorno. Il numero uno dell'industria petrolifera dello
Stato libico si è dichiarato d'accordo. La ragione di tanto pessimismo? I
grandi giacimenti che hanno fornito il grosso della produzione di petrolio
sono stati scoperti negli anni Sessanta e adesso rendono sempre meno. Mentre
la scoperta di pozzi di grandi dimensioni è sempre più rara.
Brown ha recentemente scritto un libro ('Plan B 3.0, Mobilizing to Save
Civilization') nel quale lancia l'allarme e propone un progetto per superare
la crisi prossima ventura. Lo abbiamo intervistato.
La fine dell'era petrolio è già stata annunciata altre volte. Che cosa c'è di
diverso oggi?
"Diverse cose sono cambiate. Primo: il prezzo del barile è intorno ai 100
dollari. Secondo: per la prima volta è diminuita la produzione di petrolio
dell'Arabia Saudita. Non sappiamo con certezza se sia accaduto per ragioni
politiche o geologiche, ma se la produzione saudita sta davvero declinando,
come io credo, allora l'economia mondiale non sarà più quella di ieri. Terzo:
i 20 maggiori giacimenti petroliferi sono stati tutti scoperti tra il 1914 e
il 1979. Sono quasi trent'anni che non se ne scopre più uno di grandi
dimensioni: l'unico è il Kashagan, nel Kazakhstan, che pur essendo enorme non
rientra nei primi 20 in classifica".
E i vecchi giacimenti si stanno esaurendo?
"Quelli del mare del Nord sono arrivati al picco della produzione nel '99 e
ora rendono il 50 per cento in meno. Quelli norvegesi hanno toccato il massimo
nel 2000, ora sono scesi del 20 per cento. Su questi due abbiamo dati
trasparenti, mentre sul Medio Oriente si sa poco".
L'Eia, l'Energy Information Administration, che è un organo del governo Usa,
prevede che la produzione mondiale di petrolio salirà a 118 milioni di barili
al giorno nel 2030. Perché previsioni ottimistiche così diverse dalle sue?
"L'Eia usa dati prodotti dagli economisti, i quali si limitano a prevedere
quale sarà la domanda. Danno per scontato che l'offerta soddisferà la domanda
perché così è sempre stato. A prevedere che il petrolio è arrivato al massimo
della produzione sono in parecchi, ma sono quasi tutti geologi. Con
un'eccezione: Matt Simmons, un banchiere d'affari texano specializzato nel
business del petrolio. Ha pubblicato un libro che prevede esattamente quello
che sta accadendo".
Come ha fatto?
"Siccome i sauditi sono molto restii a fornire informazioni, lui è andato a
leggersi 123 articoli scritti da diversi geologi che hanno studiato i
giacimenti di quell'area. È arrivato alla conclusione che la produzione di
petrolio in Arabia Saudita comincerà a declinare. Pare che abbia ragione".
Il presidente di Exxon-Mobil, Rex Tillerson, sostiene che, se le aziende
petrolifere avessero più facile accesso alle riserve, i prezzi scenderebbero.
Lei cosa ne pensa?
"Tillerson ha ragione. Ma ci sono alcune cose da precisare. I paesi produttori
di petrolio sono in preda alla sindrome della scarsità. Sanno che devono far
durare le loro scorte il più a lungo possibile, e non accelerarne
l'esaurimento. Hanno un punto di vista ben diverso rispetto alle società
petrolifere, che invece vogliono massimizzare i profitti a breve scadenza,
senza curarsi delle prossime generazioni. È vero che le compagnie petrolifere,
in particolare la Exxon, hanno sviluppato tecnologie che consentono di
estrarre più petrolio. Ma dubito che oggi i produttori di petrolio vogliano
affidare i propri pozzi a queste aziende".
Ha mai provato a calcolare fino a dove potrebbe salire il prezzo del barile se
la produzione di petrolio cominciasse a calare?
"Nessuno lo sa, ma penso che potrebbe toccare facilmente i 200 dollari, un
prezzo che distruggerebbe intere economie. Oggi il grano è legato al petrolio.
Quando il prezzo del barile aumenta, sale anche quello del grano. Il mercato
del cibo è sempre più legato a quello dell'energia. È una situazione del tutto
nuova che molti economisti non hanno ancora messo a fuoco: l'aumento dei
prezzi dipende dalla pressione del mercato energetico".
Se la produzione di petrolio cominciasse a calare, quali sono i settori
industriali più vulnerabili?
"Il trasporto aereo è in prima fila, perché il combustibile è una componente
importante dei suoi costi industriali. Un'altra industria sensibile è quella
alimentare. Negli Stati Uniti gran parte della verdura cresce in California ed
è consumata nel Nord-Est: deve attraversare in camion tutto il Paese. Il
supermercato vicino a casa mia d'inverno compra la frutta in Cile. Ma se i
prezzi del petrolio si impennano, queste abitudini diventeranno sempre meno
economiche. In futuro mangeremo alimenti più legati alle stagioni e al
territorio".
Ci spieghi che cosa si potrebbe fare subito negli Stati Uniti.
"Ho lanciato una campagna per il risparmio energetico. Gli Stati Uniti
consumano più benzina, da soli, dei 20 paesi messi insieme che la seguono
nella classifica dei consumi. In America abbiamo il 30 per cento delle
automobili del mondo, e bruciamo il 40 per cento della benzina. C'è un enorme
spazio per aumentare l'efficienza del sistema Usa e per ristrutturare il
trasporto urbano".
Più auto elettriche?
"Sta emergendo la possibilità di usare auto ibride: la Toyota Prius è un buon
esempio. Ha una batteria molto potente. Aggiungendone una seconda, con la
possibilità di ricaricarla, già oggi si potrebbero compiere le brevi distanze
andando a elettricità. Se è vero che siamo arrivati al picco della produzione
di petrolio, domani il mondo sarà ben diverso da quello previsto dalla World
Bank e dal Fondo monetario".
Si spieghi meglio...
"Tutti prevedevano una grande crescita economica, e la World Bank immaginava
che l'economia mondiale sarebbe raddoppiata o triplicata. Non credo che sarà
così. In futuro ci potrà anche essere una crescita, ma comporterà un grande
cambiamento nell'economia globale, nei consumi energetici, nei trasporti. Gli
Stati Uniti dovranno spostare gli investimenti dalle strade alle ferrovie.
Resta da capire se, a causa di questo choc, la popolazione mondiale continuerà
a crescere".
ENRICO PEDEMONTE